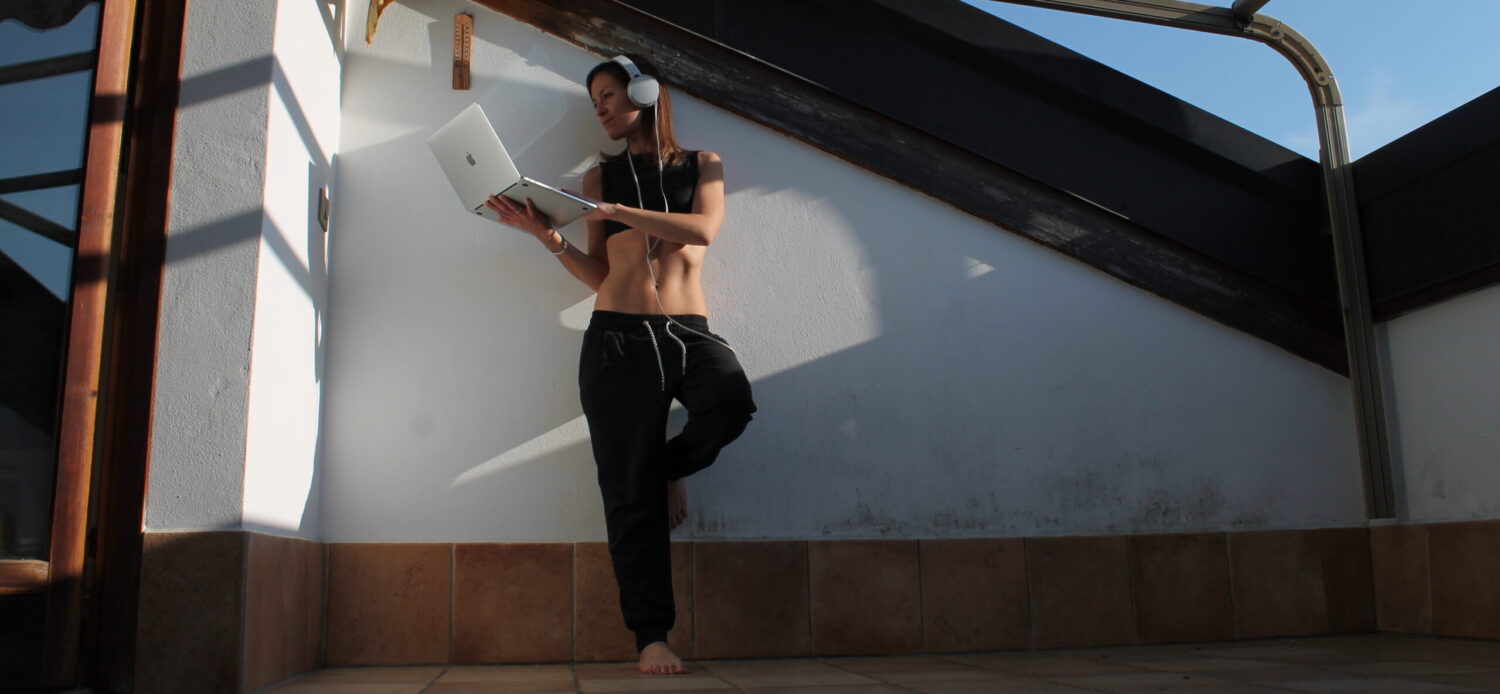Manga soldato
Il potere comunicativo delle immagini non è mai stato un segreto. Temute, contestate, sfruttate per le loro potenzialità, esse sono sempre state utilizzate dalle istituzioni per veicolare informazioni, idee e valori di ogni sorta. Quando saper leggere e scrivere era un privilegio di pochi e la maggior parte della gente viveva come appuntamento sociale più importante della settimana l’andare a messa la domenica; i preti della Chiesa cristiana comunicavano ai fedeli un verbo latino incomprensibile, accompagnato dall’unica parafrasi possibile: dipinti e affreschi sacri ad adornare le pareti delle cattedrali. Dei veri e propri percorsi per immagini capaci di guidare le masse di credenti dentro un rito altrimenti distaccato e inarrivabile.
Ancor prima fu la filosofia antica a dimostrare l’insostituibile apporto figurativo alla conoscenza. Sebbene Platone mettesse in guardia l’uomo di fronte alle insidie e alla duplicità misera delle immagini, accusate di essere mere copie della realtà e per questo ontologicamente povere; in molti dei suoi scritti vi ricorse egli stesso per poter colmare quel vuoto lasciato da un linguaggio scientifico incapace di dar conto di molti concetti. Per non parlare poi del ruolo avuto dall’arte e dal cinema nelle dittature del XX secolo, durante le quali le immagini divennero mezzo prediletto per una serrata propaganda.
NeI primi anni 2000 il filosofo e inconologo Mitchell teorizzava il cosiddetto pictorial turn, una “svolta iconica” che avrebbe portato, nella storia recente, il ruolo dell’immagine alla ribalta – dopo secoli di rigetto e persecuzioni – diventando così fondamentale per una cultura contemporanea divisa tra video su youtube, canali televisivi e continuamente insidiata da una pubblicità insistente e onnipresente.
Balle. La verità è che il pictorial turn non è una scoperta recente. C’è sempre stato, a fasi alterne. Ci sono stati periodi in cui la parola ha predominato, e altri in cui era l’immagine a fare da regina. Di più: all’interno delle stesse epoche hanno sempre convissuto culture estremamente differenti tra loro, alcune fondate, come quella occidentale, sull’egemonia delle figure; altre – ad esempio quella islamica o ebrea – basate sul potere della parola e dell’ascolto. Insomma, si potrebbe dire che, oggi come ieri, c’è chi ragiona con gli occhi e chi con le orecchie. È semplicemente un fatto culturale.
Eppure alla fin fine chiunque debba montare uno scaffale comprato all’Ikea, che sia italiano o mussulmano, americano o giapponese, avendo in mano il libretto delle istruzioni finisce con l’affidarsi ai disegni. E questo perché mostrare qualcosa e dire qualcosa non è la stessa cosa. Le immagini non sono solo un compendio, l’illustrazione copiativa di qualche concetto che sarebbe ugualmente esprimibile a parole. Le immagini veicolano un significato proprio, un contenuto non dicibile ma solo visibile. Ed estremamente potente, per giunta – Platone ci aveva visto giusto.

Da qui il loro sfruttamento incondizionato da parte delle istituzioni ogni qual volta avessero il bisogno di comunicare con la grande massa della popolazione. Un paio di giorni fa ho letto sull’Internazionale un articolo[1] di Matthew Brummer pubblicato sul The Diplomat (un magazine online di base a Tokyo) che parlava di come l’esercito giapponese stia facendo leva sull’industria culturale per condizionare l’opinione pubblica di un popolo in larga misura antimilitarista. L’intento sarebbe quello di far rinascere dalla proprie ceneri l’industria bellica giapponese, trasmettendo «un’immagine non minacciosa delle forze di autodifesa (che di fatto sono un esercito)»[2]. Per farlo l’esercito nipponico ha deciso di servirsi delle anime e dei manga (rispettivamente film animati e fumetti), popolarissimi nella cultura giapponese, in particolare insistendo sul principio del moe, ossia la reazione cognitiva ed emotiva generata nella gente dalle immagini di fantasia. In realtà le classi dirigenti dell’isola hanno già sperimentato per decenni il potenziale di efficacia che il moe possiede sulla popolazione giapponese, attuando una vera e propria strategia di commercializzazione della tenerezza tipica dei manga come strumento di marketing e di comunicazione pubblica in ambito politico, economico, letterario e persino educativo. Tuttavia, a mio avviso, se la pubblicazione di una Storia del Giappone[3] in versione manga, riconosciuta come testo ufficiale per le scuole pubbliche da parte del Ministero dell’Istruzione, possa essere un fatto curioso ma potenzialmente utile per avvicinare alla storia una generazione di ragazzi cresciuti a suon di cartoni animati e videogiochi; ritengo invece allarmante la strumentalizzazione dell’emotività dell’opinione pubblica a fini propagandistici e militarizzanti. Credo che sfruttare il moe per educare una popolazione pacifista e contraria all’istituzione di un esercito (per altro vietato dall’articolo 9 della costituzione giapponese) alla guerra come strumento buono e giusto della vita della nazione sia propriamente pericoloso.
Non che la collaborazione tra esercito e industria dell’immagine sia cosa nuova agli occhi del mondo: fin dalla sua nascita, la più grande macchina cinematografica mai esistita – Hollywood – ha stretto con il Pentagono un vero e proprio contratto che permette un vantaggio per entrambe le parti. Sigillato all’ombra della nota figura dello zio Sam, l’accordo permette agli studi televisivi di usare aree militari e attrezzature dell’esercito per girare scene di guerra in film del calibro di X-man e Transformers; di contro il Pentagono può sfruttare il potere persuasivo del cinema per arrivare in ogni casa – americana e non solo -, veicolando i propri principi e valori di violenza ed eroismo.
È anche questo in potere alle immagini: trasformare cinema e tv in veri e propri uffici di reclutamento virtuale.
Quali siano le conseguenze non è difficile da capire.
[2] Matthew Brummer, cit.
[3] Edita dalla casa editrice Chuo Koronsha.